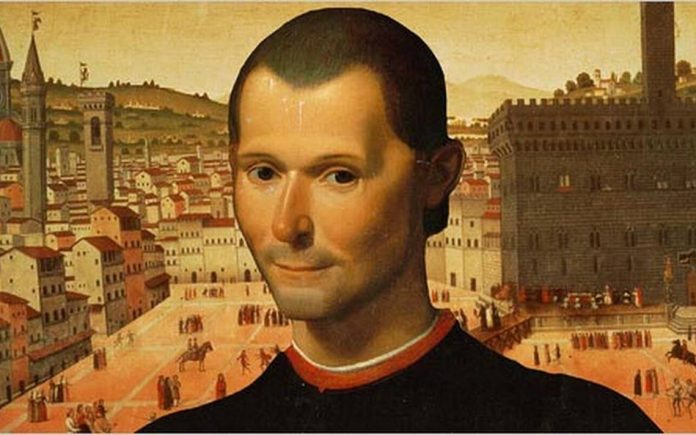
Che Machiavelli – nella a lui contemporanea vivacissima polemica sviluppatasi attorno alla sentita questione della lingua – non fosse d’accordo né con la tesi “cortigiana” di Baldassar Castiglione né con quella “trecentesca” propugnata da Pietro Bembo, appare del tutto evidente dallo stile utilizzato sia nel Principe che nelle altre sue opere letterarie in volgare, dove domina quello che possiamo chiamare un fiorentino “parlato”. Ed a confermare la sua scelta, come pienamente e polemicamente consapevole, c’è un interessantissimo testo, il Discorso intorno alla nostra lingua, la cui attribuzione non è però ancora del tutto certa nonostante il figlio Bernardo glielo attribuisca, che Niccolò Machiavelli avrebbe scritto fra il 1524 e il 1525. Inserendosi a gamba tesa nella disputa tra i sostenitori della linea bembiana, che proponevano come modello il toscano letterario del Trecento, e i fautori della teoria cortigiana, che ritenevano preferibile la lingua delle cancellerie in quanto strumento collaudato di comunicazione interregionale, il Segretario fiorentino, con energia, rivendica invece il primato del fiorentino vivo e parlato, cioè di una lingua naturale.
 Il Discorso ovvero dialogo in cui si esamina, se la lingua, in cui scrissero Dante, il Boccaccio, e il Petrarca, si debba chiamare italiana, tosca, o fiorentina fu pubblicato la prima volta solo nel 1730, come appendice all’Ercolano di Benedetto Varchi, ma circolò a lungo in forma manoscritta negli ambienti letterari impegnati nella discussione sulla lingua, e rappresenta sostanzialmente quel che è credibile che Machiavelli pensasse della questione, caratterizzandosi anche per l’uso di molti modi di dire e della caustica ironia tipici del Segretario fiorentino.
Il Discorso ovvero dialogo in cui si esamina, se la lingua, in cui scrissero Dante, il Boccaccio, e il Petrarca, si debba chiamare italiana, tosca, o fiorentina fu pubblicato la prima volta solo nel 1730, come appendice all’Ercolano di Benedetto Varchi, ma circolò a lungo in forma manoscritta negli ambienti letterari impegnati nella discussione sulla lingua, e rappresenta sostanzialmente quel che è credibile che Machiavelli pensasse della questione, caratterizzandosi anche per l’uso di molti modi di dire e della caustica ironia tipici del Segretario fiorentino.
Machiavelli, in quest’opera, afferma sostanzialmente come la lingua da preferirsi sia il fiorentino contemporaneo, in quanto idioma per natura superiore a tutti gli altri e per questo lingua sulla quale sarebbe poi nato il volgare letterario italiano stesso, come dimostra proprio l’opera di Dante Alighieri, nonostante, mentendo, lo stesso Dante nel suo De vulgari eloquentia asserisca il contrario. Gran parte del testo, infatti, appare sotto forma di gustosissimo dialogo fra Niccolò e Dante, in cui Dante è incalzato da Machiavelli, che cita scaltramente alcuni versi dalla Divina Commedia a supporto della sua tesi per smentire l’Alighieri, che alla fine è costretto ad ammettere che nel suo poema egli non usò una lingua (come da lui falsamente teorizzato) “illustre”, con caratteri sovraregionali, bensì il fiorentino parlato del suo tempo. E tutto questo, cioè quanto teorizzato nel suo trattato in latino, Dante l’avrebbe fatto solo per motivi politici, per denigrare la sua patria che l’aveva esiliato: «Dante il quale in ogni parte mostrò d’esser per ingegno, per dottrina et per giuditio huomo eccellente, eccetto che dove egli hebbe a ragionare della patria sua, la quale, fuori d’ogni humanità et filosofico instituto, perseguitò con ogni spetie d’ingiuria. E non potendo altro fare che infamarla, accusò quella d’ogni vitio, dannò gli uomini, biasimò il sito, disse male de’ costumi et delle legge di lei; et questo fece non solo in una parte de la sua cantica, ma in tutta, et diversamente et in diversi modi: tanto l’offese l’ingiuria dell’exilio, tanta vendetta ne desiderava!».
 Nel dialogo con Dante, Machiavelli non nega la presenza di vocaboli non fiorentini nella lingua di Dante, dove alcuni latinismi ed alcuni lombardismi o venetismi sono evidenti, ma ci tiene ad evidenziare «come le lingue non possono esser semplici, ma conviene che sieno miste coll’altre lingue; ma quella lingua si chiama d’una patria, la quale converte i vocaboli ch’ella ha accattati da altri, nell’uso suo, ed è sì potente, che i vocaboli accattati non la disordinano ma la disordina loro, perché quello ch’ella reca da altri, lo tira a sé in modo, che par suo, e gli uomini che scrivono in quella lingua, come amorevoli di essa, debbono far quello che hai fatto tu, ma non dir quello che hai detto tu; perché se tu hai accattato da’ Latini, e da’ forestieri assai vocaboli, se tu n’hai fatti de’ nuovi, hai fatto molto bene; ma tu hai ben fatto male a dire, che per questo ella sia divenuta un’altra lingua». E a dimostrazione di quanto sia stata potente la fiorentinizzazione del volgare letterario italiano, Machiavelli porta a testimonianza anche il fatto che molti vocaboli schiettamente fiorentini, che prima di Dante nessuno aveva mai usato in altri dialetti, dopo il successo della Divina Commedia si sono invece spesso ritrovati utilizzati in molti testi di altri autori non toscani, al punto da divenir percepiti ora come nomi d’uso comune a tutti: «Ma quello che inganna molti circa i vocaboli comuni è, che tu e gli altri che hanno scritto, essendo stati celebrati, e letti in varj luoghi, molti vocaboli nostri sono stati imparati da molti forestieri, e osservati da loro, talché di proprii nostri son diventati comuni. E se tu vuoi conoscer questo, arrecati innanzi un libro composto da quelli forestieri, che hanno scritto dopo voi, e vedrai quanti vocaboli egli usano de’ vostri, e come e’ cercano d’imitarvi: e per aver riprova di questo fa loro leggere libri composti dagli uomini loro avanti che nasceste voi, e si vedrà che in quelli non fia né vocabolo né termine; e così apparirà che la lingua in che essi oggi scrivono, è la vostra, e per consequenza vostra; e la vostra non è comune colla loro: la qual lingua ancoraché con mille sudori cerchino d’imitare, nondimeno, se leggerai i loro scritti, vedrai in mille luoghi essere da loro male, e perversamente usata, perch’egli è impossibile che l’arte possa più che la natura».
Nel dialogo con Dante, Machiavelli non nega la presenza di vocaboli non fiorentini nella lingua di Dante, dove alcuni latinismi ed alcuni lombardismi o venetismi sono evidenti, ma ci tiene ad evidenziare «come le lingue non possono esser semplici, ma conviene che sieno miste coll’altre lingue; ma quella lingua si chiama d’una patria, la quale converte i vocaboli ch’ella ha accattati da altri, nell’uso suo, ed è sì potente, che i vocaboli accattati non la disordinano ma la disordina loro, perché quello ch’ella reca da altri, lo tira a sé in modo, che par suo, e gli uomini che scrivono in quella lingua, come amorevoli di essa, debbono far quello che hai fatto tu, ma non dir quello che hai detto tu; perché se tu hai accattato da’ Latini, e da’ forestieri assai vocaboli, se tu n’hai fatti de’ nuovi, hai fatto molto bene; ma tu hai ben fatto male a dire, che per questo ella sia divenuta un’altra lingua». E a dimostrazione di quanto sia stata potente la fiorentinizzazione del volgare letterario italiano, Machiavelli porta a testimonianza anche il fatto che molti vocaboli schiettamente fiorentini, che prima di Dante nessuno aveva mai usato in altri dialetti, dopo il successo della Divina Commedia si sono invece spesso ritrovati utilizzati in molti testi di altri autori non toscani, al punto da divenir percepiti ora come nomi d’uso comune a tutti: «Ma quello che inganna molti circa i vocaboli comuni è, che tu e gli altri che hanno scritto, essendo stati celebrati, e letti in varj luoghi, molti vocaboli nostri sono stati imparati da molti forestieri, e osservati da loro, talché di proprii nostri son diventati comuni. E se tu vuoi conoscer questo, arrecati innanzi un libro composto da quelli forestieri, che hanno scritto dopo voi, e vedrai quanti vocaboli egli usano de’ vostri, e come e’ cercano d’imitarvi: e per aver riprova di questo fa loro leggere libri composti dagli uomini loro avanti che nasceste voi, e si vedrà che in quelli non fia né vocabolo né termine; e così apparirà che la lingua in che essi oggi scrivono, è la vostra, e per consequenza vostra; e la vostra non è comune colla loro: la qual lingua ancoraché con mille sudori cerchino d’imitare, nondimeno, se leggerai i loro scritti, vedrai in mille luoghi essere da loro male, e perversamente usata, perch’egli è impossibile che l’arte possa più che la natura».
Pertanto, nascendo l’attuale lingua comune dal fiorentino naturalmente parlato da Dante, per Machiavelli non sussiste alcuna questione circa l’uso da farsi per una lingua letteraria: per lui, come fece l’Alighieri, non basta che seguire la sua natura, e scrivere nel suo fiorentino vivo, quello che parla quotidianamente, al quale comunque, alla fine, in caso di dubbio e per gusto, tutti quelli che scrivono in volgare letterario, lingua derivata dai grandi scrittori toscani del passato, son costretti a venire.














