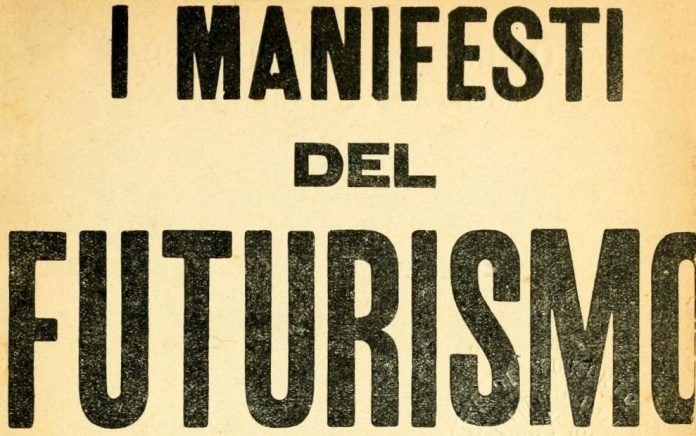
Con il Manifesto del 1909, pubblicato sul parigino Le Figaro, Filippo Tommaso Marinetti lanciava alla grande il suo movimento futurista, che nel 1912 si arricchiva del Manifesto tecnico della letteratura futurista, con il quale proclamava una radicale e polemica rivoluzione della lingua italiana, all’insegna del paroliberismo, per ottenere una nuova letteratura, liberata da tutte le regole, anche da quelle della grammatica, dell’ortografia e della punteggiatura: «La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno».
 Una furia anti-passatista, quella di Marinetti, che, come voleva distrutti i musei, le biblioteche e le accademie, allo stesso modo puntava in letteratura alla rottura degli schemi metrici e strutturali, alle parolibere ed all’eliminazione della vecchia divisione fra prosa e poesia, per ottenere il continuum del poema in prosa. Scontrandosi ovviamente con chi invece della letteratura aveva ben altra idea, come il vate Gabriele D’Annunzio, con il quale i rapporti non possono che essere ambigui: in pubblico, pacche sulle spalle e, platealmente, D’Annunzio porterà un mazzo di rose rosse a Marinetti, ferito a una coscia da una granata austriaca, ma, come ben sottolinea Silverio Novelli: “Chi domina nell’orto delle lettere italiche ha parole di sprezzo verso i parvenu dell’anti-cultura. Ai propri amici, il vate D’Annunzio confida che Marinetti è «una nullità tonante», «un cretino fosforescente», meglio ancora: «un cretino con qualche lampo d’imbecillità». Marinetti ai suoi dice che D’Annunzio, «noioso e anacronistico», è la «Montecarlo di tutte le letterature». A ben vedere, l’irritazione di D’Annunzio, prima donna nella vita mondana e sostenitore del binomio arte-vita, è motivata, perché Marinetti è un agitatore artistico di grandi capacità, chiama luce su di sé, oscura gli altri. La raffica di manifesti teorici, le pubbliche serate di letture ed animazione (anche rissose), le prime opere dei futuristi (fondamentale la prima antologia, I poeti futuristi, del 1912) disordinano il paesaggio delle patrie lettere (e delle arti) e hanno notevole eco, raccogliendo adepti e simpatie in tutt’Europa, specialmente in Francia”.
Una furia anti-passatista, quella di Marinetti, che, come voleva distrutti i musei, le biblioteche e le accademie, allo stesso modo puntava in letteratura alla rottura degli schemi metrici e strutturali, alle parolibere ed all’eliminazione della vecchia divisione fra prosa e poesia, per ottenere il continuum del poema in prosa. Scontrandosi ovviamente con chi invece della letteratura aveva ben altra idea, come il vate Gabriele D’Annunzio, con il quale i rapporti non possono che essere ambigui: in pubblico, pacche sulle spalle e, platealmente, D’Annunzio porterà un mazzo di rose rosse a Marinetti, ferito a una coscia da una granata austriaca, ma, come ben sottolinea Silverio Novelli: “Chi domina nell’orto delle lettere italiche ha parole di sprezzo verso i parvenu dell’anti-cultura. Ai propri amici, il vate D’Annunzio confida che Marinetti è «una nullità tonante», «un cretino fosforescente», meglio ancora: «un cretino con qualche lampo d’imbecillità». Marinetti ai suoi dice che D’Annunzio, «noioso e anacronistico», è la «Montecarlo di tutte le letterature». A ben vedere, l’irritazione di D’Annunzio, prima donna nella vita mondana e sostenitore del binomio arte-vita, è motivata, perché Marinetti è un agitatore artistico di grandi capacità, chiama luce su di sé, oscura gli altri. La raffica di manifesti teorici, le pubbliche serate di letture ed animazione (anche rissose), le prime opere dei futuristi (fondamentale la prima antologia, I poeti futuristi, del 1912) disordinano il paesaggio delle patrie lettere (e delle arti) e hanno notevole eco, raccogliendo adepti e simpatie in tutt’Europa, specialmente in Francia”.
 Ma alla fine, del Futurismo, che cos’è restato? Per Maria Luisa Altieri Biagi: «ha contribuito a snellire la nostra sintassi, a semplificare la nostra morfologia, a rinnovare, attraverso procedimenti analogici, il nostro lessico» e certamente di quell’esperienza molto c’è ancora nella nostra lingua, soprattutto nel campo pubblicitario e nel mondo dei fumetti, e, anche se Marcello Durante drastico ed ironico affermava che il Futurismo «non ha influenzato la lingua comune [ma] potrebbe essere […] l’idioma del Tremila», per Giuliana Rotondi è invece alla base della nostra comunicazione di massa.
Ma alla fine, del Futurismo, che cos’è restato? Per Maria Luisa Altieri Biagi: «ha contribuito a snellire la nostra sintassi, a semplificare la nostra morfologia, a rinnovare, attraverso procedimenti analogici, il nostro lessico» e certamente di quell’esperienza molto c’è ancora nella nostra lingua, soprattutto nel campo pubblicitario e nel mondo dei fumetti, e, anche se Marcello Durante drastico ed ironico affermava che il Futurismo «non ha influenzato la lingua comune [ma] potrebbe essere […] l’idioma del Tremila», per Giuliana Rotondi è invece alla base della nostra comunicazione di massa.
Certamente, però, come acutamente ha notato Pier Vincenzo Mengaldo: «l’unico seguace di Marinetti fu appunto Marinetti», e per Silverio Novelli il Futurismo fu: “traditore di sé stesso nella propria prassi”, perché “i diktat teorici marinettiani sono accolti solo in parte: sì al simultaneismo, sì all’assenza di punteggiatura, sì alla sintassi nominale, sì a certe analogie sorprendenti; no, viceversa, all’eliminazione degli aggettivi qualificativi, no alla scomparsa delle similitudini, introdotte perfino dal tradizionale come (in luogo dei sintetici doppi analogici, del tipo donna-golfo, donna-risacca), no alla scomparsa dell’io, no alla sostituzione del verso libero con le parole in libertà”. Insomma, anche nei migliori degli autori che si dichiararono futuristi, come Ardengo Soffici o Aldo Palazzeschi, “l’immaginazione si riprende certi fili che la teoria e la prassi marinettiana avevano reciso” ed una nuova grammatica unitaria il futurismo non la fonda.














