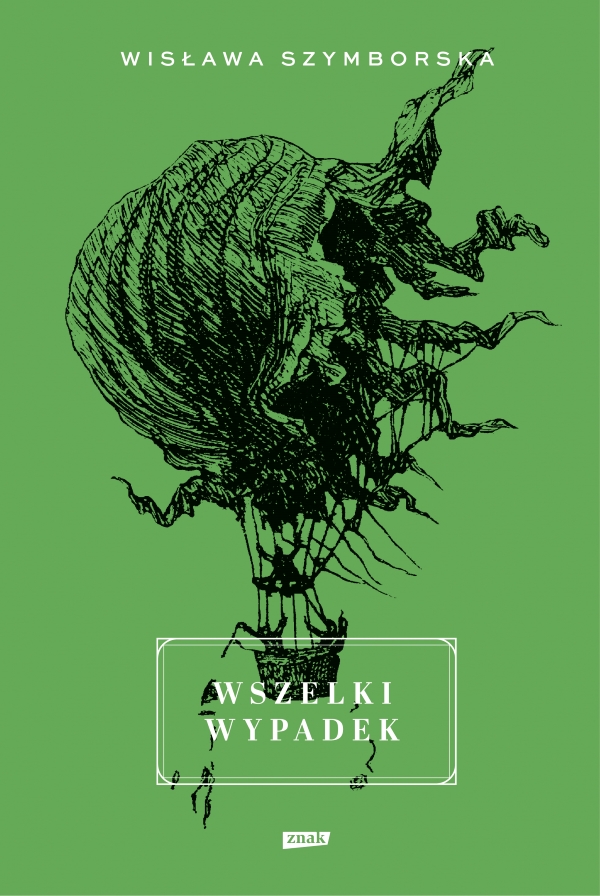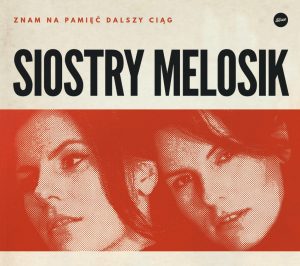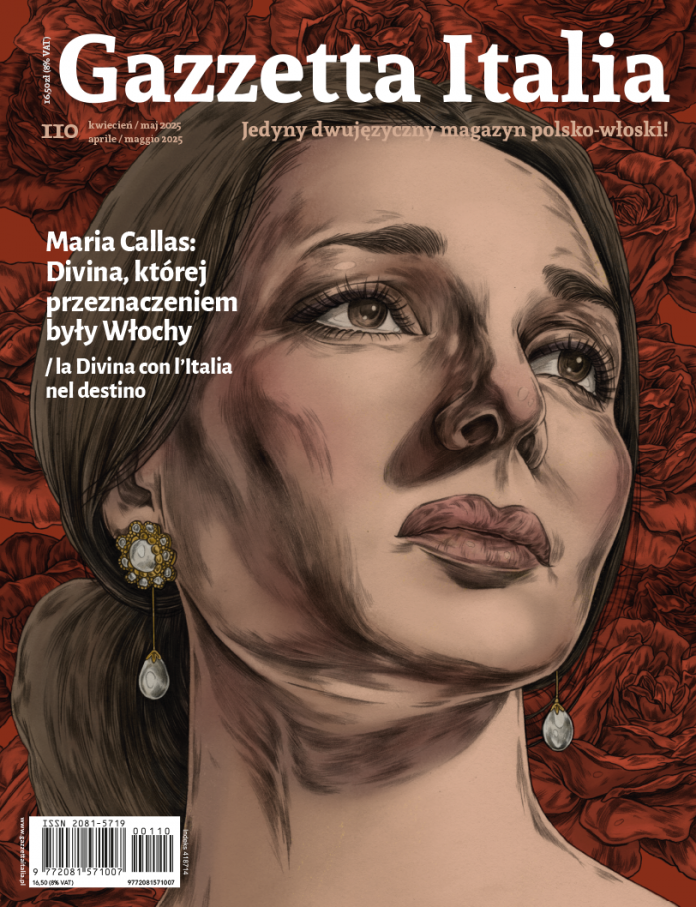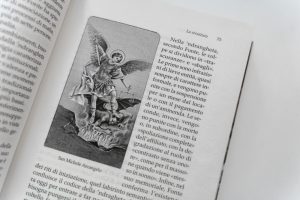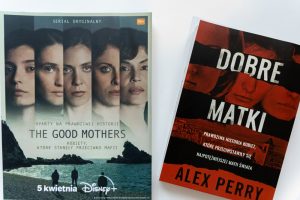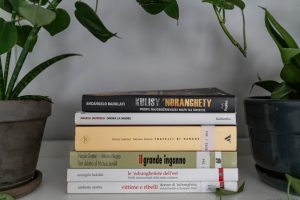Siamo ormai nel pieno della primavera, stagione della rinascita e del passaggio dal freddo invernale al caldo dell’estate. Senza addentrarci in disquisizioni sul cambiamento climatico, l’imprevedibilità metereologica e vecchi adagi quali “non esistono più le mezze stagioni”, è possibile, quasi per gioco, compilare una ipotetica playlist tematica che esplori la relazione tra uomo e primavera, cercando di capire se spostandosi dalla Polonia all’Italia si notino essenziali analogie o piuttosto spunti di riflessione antitetici.
La primavera è, come detto, stagione di rinascita, di profumi, colori, fiori e luce. Tutto questo lo troviamo sicuramente nel brano citato nel titolo, ovvero “Wiosna, ach to ty”, pubblicato nel 1986 dall’indimenticato Marek Grechuta:
Dzisiaj rano niespodzianie
zapukała do mych drzwi:
wcześniej niż oczekiwałem
przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto,
posadziłem vis a vis.
Zapachniało zajaśniało
wiosna, ach to ty!
Stamattina all’improvviso
ha bussato alla mia porta:
questi giorni più caldi sono arrivati
prima di quanto mi aspettassi
Le ho tolto il cappotto bagnato,
l’ho fatta sedere di fronte a me.
Profumava, brillava:
primavera, ah sei tu!
È un’immagine gioiosa, quella proposta dal cantautore di Piwnica pod Baranami, che ci rimanda tramite un’allegoria alla sorpresa di chi si trova catapultato fuori dall’inverno quasi senza preavviso.
Di una primavera che inebria i sensi e risveglia dal torpore dell’inverno cantavano invece nel 1976 Skaldowie in “Wszystko kwitnie wkoło”:
Wiosna: cieplejszy wieje wiatr
Wiosna: znów nam ubyło lat
Wiosna: wiosna wkoło, rozkwitły bzy
Śpiewa skowronek nad nami
Drzewa strzeliły pąkami
Wszystko kwitnie wkoło – i ja, i ty
Primavera: soffia un vento più caldo.
Primavera: ci sentiamo di nuovo giovani.
Primavera tutto intorno, sboccia il sambuco,
canta l’allodola sopra di noi,
gli alberi si riempiono di germogli.
Tutto fiorisce intorno – anche io e te
Ancora una volta un pastiche di luoghi comuni quale calore, sole, uccellini, boccioli e soprattutto profumi – qui nello specifico il profumo del sambuco, onnipresente in Polonia in primavera, nei parchi come nelle canzoni; come non ricordare a tal proposito l’incipit della celeberrima “Małgośka” (1974), di Maryla Rodowicz:
To był maj, pachniała Saska Kępa
szalonym, zielonym bzem…
Era maggio. E l’aria di Saska Kępa profumava
del folle, verde sambuco in fiore
Il termine bez in realtà può indicare sia il sambuco (czarny bez) che il lillà bianco (biały bez), come ci ricorda Jerzy Połomski che nel 1973 ci regalava con “Kiedy znów zakwitną białe bzy” questa cartolina primaverile:
Kiedy znów zakwitną białe bzy,
Bzów aleją parki będą szły.
Pojmą to najprościej,
Że jest czas miłości,
Bo zakwitły przecież białe bzy,
Quando di nuovo fioriranno i lillà bianchi,
i parchi saranno attraversati da un viale di lillà.
Lo capiranno nel modo più semplice,
che è il tempo dell’amore,
perché sono fioriti, dopotutto, i lillà bianchi.
E nel 1980 Andrzej Rosiewicz in “Lubię wiosnę“ cantava:
Lubię wiosnę, kiedy kwiatem kwitną bzy:
wtedy bardziej lubię ciebie, a mnie ty.
Gdy jaśminy pachną, wiosny pierwszy znak
serca łatwo znajdą jeden wspólny takt
Amo la primavera, quando fiorisce il lillà: (o il sambuco? ndt)
allora mi piaci ancor di più, ed io a te.
Quando profuma il gelsomino, primo segno della primavera
i cuori facilmente vibrano all’unisono
Il tema dei profumi dei giardini in fiore nei mesi primaverili non è ovviamente presente solo nelle canzoni polacche. Pensiamo a “Era de Maggio”, famosa canzone napoletana del 1885, dove abbiamo:
Era de maggio, e te cadeono ‘nzino
a schiocche a schiocche li ccerase rosse…
Fresca era ll’aria e tutto lu ciardino
addurava de rose a ciente passe.
Era maggio, e ti cadevano in grembo
le ciliege rosse, a ciocche.
L’aria era fresca, e tutto il giardino
profumava di rose a cento passi di distanza.
Il connubio tra la rigogliosa natura primaverile e lo sbocciare dell’amore pare quasi scontato, ad ogni latitudine. Spostandosi dalla Campania alla Toscana, ecco cosa cantava nel 1941 Alberto Rabagliati nella celeberrima “Mattinata fiorentina”:
È primavera, svegliatevi bambine:
alle Cascine messere Aprile fa il rubacuor!
E a tarda sera, madonne fiorentine,
quanti ricordi vi desteranno i prati in fior…
Cercando atmosfere gioiose e spensierate, più di recente (1997) abbiamo Marina Rei, in una famosa cover del brano “You to Me Are Everything” dal titolo italiano “Primavera”:
Respiriamo l’aria e viviamo aspettando primavera
Siamo come fiori prima di vedere il sole a primavera
Ci sentiamo prigioniere della nostra età
Ma con il cuore in catene di felicità
Sì, respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera
Ancora una volta abbiamo fiori, amori, felicità… Ma non si pensi ora che la primavera debba necessariamente evocare solo quadri bucolici ed amorosi! Anzi, per assurdo pare che una gran parte degli autori abbia utilizzato le tematiche primaverili affiancandole, per contrasto, a visioni cupe o narrazioni tristi. Chi non ricorda ad esempio l’iconico brano del 1972 “I giardini di marzo” di Lucio Battisti (su testo di Mogol)? Le strofe, in tonalità minore, sono un susseguirsi di quadri cupi e malinconici:
Il carretto passava e quell’uomo gridava “gelati”.
Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti.
Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti
Il piu’ bello era nero coi fiori non ancora appassiti
E anche laddove il ritornello, passando ad una più serena tonalità maggiore, ci presenta scorci di paesaggi primaverili che sembrano suggerire una rinascita, il testo termina con la più triste delle autoanalisi:
Fiumi azzurri e colline e praterie
Dove corrono dolcissime le mie malinconie
L’universo trova spazio dentro me
Ma il coraggio di vivere quello ancora non c’è
Potrebbe sembrare un caso, ma andando oltre vedremo come il tema dello spleen primaverile sia piuttosto presente nella discografia italiana. Guardiamo ad esempio “Il primo giorno di primavera” dei Dik Dik, successo del 1969 (il cui stile risente sicuramente dell’influenza di “A whiter Shade of Pale”); il testo, ancora una volta scritto da Mogol, recita:
È quasi giorno, ormai, e non ho tra le braccia che il ricordo di te
Ma è tardi, devo correre: non c’è tempo per piangere
[…] Mentre nasce una primula sto morendo per te
È il primo giorno di primavera
Ma per me è solo il giorno che ho perso te.
In questo caso è chiaro che la primavera si trova al centro di una narrazione per opposti, esemplificata dalla primula che nasce, in contrasto all’autore che muore (d’amore)… Ed è così che realizziamo che questa stagione, che per millenni è stata una benedizione per i contadini, per gli autori contemporanei di canzoni diventa spesso odiosa, come ad esempio in “Maledetta primavera”, portata al secondo posto del festival di Sanremo del 1981 da Loretta Goggi.
Se per innamorarmi ancora
Tornerai, maledetta primavera
Che imbroglio, se per innamorarmi basta un’ora?
Che fretta c’era? Maledetta primavera!
Che fretta c’era, se fa male solo a me?
La primavera qui è chiaramente maledetta in quanto risveglia i sensi ed invita ad indugiare nelle tossiche dinamiche di un amore non corrisposto, evocando quindi dolore e malinconia. Le pene amorose sono del resto presenti anche in “Questa primavera” (1993) di Pino Daniele:
Pecchè sta primmavera
a te me fa’ penzà?
Chissà addò staje stasera,
si m’aje scurdato ggià…
Perchè questa primavera
mi fa pensare a te?
Chissà dove sei stasera,
Se mi hai già dimenticato…
Di esempi in linea con quelli appena presentati se ne potrebbero trovare ancora molti altri, ma si rischierebbe di dedurre erroneamente che questo approccio più malinconico e pessimista sia una prerogativa italiana. In realtà anche in Polonia (seppur molto più raramente) troviamo brani – quali ad esempio “Po niebieskim niebie” di Małgorzata Ostrowska (2012) – che seguono questo filone stilistico e narrativo:
Wiosna ma smak tęsknoty
i blado-żółtych liści;
miejskiego kurzu zapach,
piwa w podziemnym przejściu.
Wiosna ma zapach żalu
i spalin na ulicach,
i spóźnia się jak tramwaj
i ciągle każe czekać…
La primavera ha il sapore della nostalgia
e delle foglie giallo-pallide;
L’odore della polvere cittadina,
della birra nei sottopassaggi.
La primavera ha il profumo del rimpianto
e dei gas di scarico per le strade.
È in ritardo come un tram
e ti costringe sempre ad aspettare…
Sembra in effetti difficile ricondurre questo testo alla primavera (tanto più che le foglie giallo-pallide parrebbero suggerire piuttosto un’ambientazione autunnale), ma ancora una volta il testo gioca sul contrasto tra le esperienze personali dell’ascoltatore e quelle dell’autore, in uno scontro di visioni ed aspettative destabilizzante, e forse pertanto accattivante.
Anche Ørganek si unisce al coro di chi legge la primavera in chiaroscuro. Nella sua “Wiosna” del 2016 infatti ci racconta che:
Wiosną wydaje się
że koniec jest blisko;
chce się uciekać,
lecz nie wiadomo gdzie.
I znowu noce są krótsze,
i co raz więcej dnia,
a nasze ciała są chudsze,
a w nich jest więcej nas.
In primavera sembra
che la fine sia vicina:
ci vorrebbe scappare,
ma non si sa dove.
E di nuovo le notti sono più corte,
e c’è sempre più giorno,
e i nostri corpi sono più magri,
ma in essi c’è più di noi.
Totalmente opposto e’ l’approccio di Luca Carboni, che con la sua “Primavera” (1984) si muove tra l’intimismo e l’abbandono:
È primavera, e mi prende un bisogno di leggerezza,
e di pesanti passioni, e un sentimento
indefinibile al tramonto.
Dalla finestra guardo il mondo
e mi viene voglia di tuffarmi lì dentro,
e mi vien voglia di non lasciarlo mai
Come vediamo, laddove Ørganek, appesantito dai suoi pensieri, vuole scappare dalla realtà che lo opprime, Carboni desidera immergersi nel mondo che lo circonda per diventare con esso tutt’uno. Vvsioni diverse della vita, reazioni ed emozioni diverse all’arrivo della primavera.
Come abbiamo visto, dunque, quello della primavera e’ un tema ampiamente rappresentato ed utilizzato in ambito musicale in Italia come in Polonia, con uno spettro di dinamiche e tematiche vario, con diverse analogie tra le due realtà. Ma sarebbe ingiusto concludere questa carrellata senza citare quello che è forse il primo importante incontro tra testo, musica e temi primaverili della nostra cultura.
Come tutti sappiamo, intorno al 1730 Antonio Vivaldi compone il ciclo di concerti noto come “Le quattro stagioni”; indubbio è che dei quattro concerti quello più iconico e riconoscibile sia proprio “La primavera” – il cui tema, tra l’altro, è ripreso in Polonia come sigla della trasmissione “Cztery pory roku” su Polskie Radio. Quello che non tutti sanno è che, oltre a costituire un capolavoro di musica barocca descrittiva, ogni concerto era accompagnato da un sonetto, probabilmente scritto dallo stesso Vivaldi, che completava l’ascolto e fungeva in un certo senso da antesignano dei testi delle canzoni odierne. Di seguito il testo relativo alla primavera, con trasposizione in italiano corrente.
Giunt’è la Primavera e festosetti
la salutan gl’augei con lieto canto,
e i fonti allo spirar de’ zeffiretti
con dolce mormorio scorrono intanto.
Vengon’ coprendo l’aer di nero amanto
e lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti;
indi tacendo questi, gl’augelletti
di nuovo al lor canoro incanto.
E quindi sul fiorito ameno prato
al caro mormorio di fronde e piante
dorme ‘l caprar col fido can’ à lato.
Di pastoral zampogna al suon festante
danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato
di primavera all’apparir brillante.
È arrivata la primavera, e gli uccellini
la salutano gioiosi con il loro canto allegro,
e i ruscelli, mossi dal soffio dei venti di primavera,
scorrono dolcemente con un lieve mormorio.
Arrivano poi nuvole scure a coprire il cielo,
lampi e tuoni la preannunciano;
ma appena questi si placano,
gli uccellini tornano al loro canto melodioso.
E così, nel prato fiorito e sereno,
al dolce sussurro delle foglie e delle piante,
dorme il pastore accanto al suo cane fedele.
Al suono festoso di una zampogna,
ninfe e pastori danzano gioiosamente
all’arrivo splendente della primavera.